
L’anno del centenario proustiano ci ha lasciati, ma non il piacere di intrattenerci ancora un po’ con «Alla ricerca del tempo perduto», possibilmente approfondendone la lettura con contributi adatti e non banali, che possano fugare alcuni dei tanti dubbi che costituiscono il fardello del lettore della Recherche. Ora, i testi pubblicati nel 2022 (o poco prima) su Proust sono innumerevoli e non sempre “aiutano” davvero ad affinarne l’analisi. Questo articolo e il prossimo propongono e consigliano quattro validi testi critici; chi scrive non può ovviamente conoscere tutto ciò che su Proust è stato proposto al pubblico, per cui rimarranno necessariamente esclusi dall’elenco tanti altri libri utili. Ma i quattro testi prescelti, scritti da studiosi noti e più che affidabili, possono costituire per tutti un valido ausilio. Quanto segue cercherà di dimostrarlo.
1) Alberto Beretta Anguissola, Proust: guida alla Recherche, Carocci 2022.
Si tratta di un agile libro di circa 140 pagine, pubblicato nel 2018 e ripubblicato nel 2022, scritto da uno specialista in francesistica, curatore con Daria Galateria della Recherche presso Mondadori. Ed è davvero una “guida” ideale e preziosa, indicata sia per un lettore esperto che per un “neofita”. Lo si può desumere già dall’indice: si inizia con la vita e le opere di Proust e con la trama completa, riassunta in poco più di 40 pagine; si passa poi a un ambito più interpretativo con il capitolo «Fra antropologia ed estetica» (la parte più personale, in cui troviamo le proposte critiche di Anguissola) e, appunto, con «Alcune interpretazioni», un elenco ragionato e obiettivo dei “proustiani” più notevoli (tra cui lui stesso). La prima metà del testo, fino a «La trama», funge da prima fase di studio, utile per rivedere nel suo complesso la biografia e i contenuti dell’opera, a cui segue, come detto, l’approfondimento sui singoli temi dell’antropologia e dell’estetica di Proust, alcuni consueti, come la memoria o l’omosessualità, altri in genere meno trattati come l’eterogeneità dell’uomo proustiano, o la rivalutazione della stupidità. Ma l’autore ha il dono dell’originalità e spesso riesce a sorprendere il lettore. Per esempio, quando afferma che nell’opera la memoria è vista come passato che irrompe nel presente e non come presente che si “tuffa” nel passato; mentre il ricorso all’arte come “salvezza” per l’uomo postula la vita vista come sofferenza, con un pessimismo che diventa la precondizione della stessa estetica proustiana. Di alcuni personaggi unanimemente riconosciuti come positivi, come Swann, la nonna e la madre del Narratore, Anguissola mette in rilievo qualche difetto o una certa debolezza, corredando l’assunto con i necessari rinvii testuali. Il tema della malattia si collega a quello della disistima di sé, l’asse su cui ruotano le vicende del Narratore, e ovviamente a quello più generale della morte. Inoltre, i tre artisti immaginari inventati da Proust (Bergotte, Vinteuil, Elstir) in rappresentanza paradigmatica di tre diverse forme d’arte, svolgono un ruolo che i veri artisti che Proust amava, per esempio Wagner per la musica, non potevano ricoprire in maniera così esauriente. Ciò che importa all’autore è mostrare il coinvolgimento dell’uomo in tutte le principali forme d’arte: chi prova interesse per la letteratura, o per l’arte figurativa, o per la musica, e trova dei modelli perfetti, verrà attratto inevitabilmente dalle altre due esperienze artistiche e conoscerà così l’arte nella sua universalità. È il modo che ha Proust di collegare la vita con l’arte.
Ma dove Anguissola eccelle, da buon filologo, è nello studio dei significati nascosti, cioè del cosiddetto criptotesto, rinvenuto grazie al fenotesto. L’uso del criptotesto è frequente nella Recherche e raggiunge il culmine nella seconda parte del «Tempo ritrovato», quando il Narratore, a causa dell’improvvisa perdita di equilibrio, prova un inaspettato senso di felicità e ripensa alla sua visita al Battistero della basilica di San Marco, mentre ammirava un mosaico raffigurante il battesimo di Cristo. Anguissola torna a «Sodoma e Gomorra», al secondo soggiorno a Balbec e all’episodio sconvolgente di memoria involontaria riguardante la nonna. Il semplice gesto di chinarsi per sciogliere le scarpe, che lui compie, è stato effettuato dalla nonna durante il primo soggiorno a Balbec, con le conseguenze drammatiche descritte nello stesso capitolo, quello famoso delle «Intermittenze del cuore». Il gesto rimanda a un luogo comune a tutti e quattro i Vangeli, alle parole di Giovanni Battista – ben presenti al lettore di cento anni fa – in cui il santo afferma che dopo di lui verrà qualcuno più forte di lui al quale non è neppure degno di sciogliere i legacci dei sandali. Il rinvio, secondo Anguissola, non va, dunque, alla semplice presenza del Narratore e della madre nel Battistero, ma al lavacro battesimale in sé e per sé: è questo il segno che permette l’analogia con la “resurrezione” della nonna, un sacramento che cancella il peccato e dunque libera l’uomo dal senso di colpa. Ed è così che il Narratore, grazie alla memoria involontaria, si avvia a superare la sua nevrosi e a riconsiderare positivamente la sua predisposizione alla letteratura. E potrebbe esserci una valenza religiosa anche nel primo segnale di memoria involontaria, con la forma della piccola madeleine e il richiamo al gesto del sacerdote che celebra la comunione (inzuppare il biscotto nel tè e offrirlo al ragazzo). Si tratterebbe dunque di un criptotesto cristianeggiante.
Anguissola riconosce in alcuni luoghi della Recherche una malcelata spinta verso la trascendenza e l’al di là, tesi non agevole da dimostrare, anche se l’autore porta diverse prove a sostegno. Altro punto controverso è l’interpretazione del finale dell’opera, quando il trionfo della morte sembra mettere in forse l’effetto salvifico dell’Arte, o almeno la possibilità che essa esista, Arte che potrebbe essere sopraffatta dall’avvento del Nulla (lo si può leggere nelle ultime righe del capitolo sulla trama dell’opera). Sono questioni aperte, naturalmente, e Anguissola ha il merito di averle segnalate al lettore.
2) Francesco Orlando, In principio Marcel Proust, nottetempo 2022.
È una raccolta di sei testi di Francesco Orlando (1934-2010), comparsi tra il 1973 e il 2010 e raccolti da Luciano Pellegrini, dell’Università dell’Aquila, autore sia dell’introduzione che della postfazione. Più precisamente, il libro contiene cinque saggi specialistici e un’appendice («Spunti introduttivi per la lettura della Recherche di Proust», 1999), che riporta la trascrizione di una lezione per studenti liceali pisani tenuta anni prima, nel 1987. I saggi seguono un ordine tematico, non cronologico, tanto è vero che il primo della silloge è anche il più tardo (2020). Inoltre, l’appendice costituisce una lettura preliminare, l’esempio di una divulgazione riuscitissima e felice compendio del pensiero di Orlando su Proust (anzi un surrogato, visto che Orlando non raccolse mai in una sola opera le sue posizioni sulla Recherche). Critico, docente francesista e teorico della letteratura, Orlando propose lo studio del rapporto tra letteratura e psicoanalisi, come mostra il secondo dei saggi scelti da Pellegrini.
Il primo fu redatto pochi mesi prima della sua morte e fu pubblicato postumo (2010). Qui Orlando si sofferma per una volta sull’uomo Proust nel suo rapporto con la madre, esaminando in particolare l’epistolario («Proust e la madre, le lettere»). Sfidando le ire dei critici francesi, che difendevano l’interpretazione spiritualista di Proust e rifiutavano l’idea che categorie della psicanalisi potessero influenzare lo studio di un autore ormai affermato (e francese), Orlando difende l’ipotesi che l’autore avesse spostato sul personaggio della nonna – finché è presente nella narrazione – le esperienze più importanti avute con la vera madre. Questo vissuto, fatto di incomprensioni e sensi di colpa, viene attribuito nel romanzo al solo Narratore, sicché la nonna risulta una tenera altruista e con la madre c’è solo un piccolo diverbio, a Venezia. Orlando sottolinea i punti in comune tra il contenuto delle lettere e vari momenti del romanzo, legati alla fotografia o al telefono. Ma di certo, non all’omosessualità, ovviamente omessa.
«Marcelle Proust dilettante mondano, e la sua opera» (1973), secondo testo della raccolta, propone i risultati del primo corso universitario di Orlando, tenuto nel 1968, in piena contestazione studentesca (ma Orlando non era lontano dalle posizioni studentesche). L’analisi dell’opera scaturisce da una storicizzazione in chiave marxista (non infondata, si pensi alla sociologia dello snobismo, così centrale nella Recherche) che in sede prettamente letteraria si abbina all’idea di un’opera lontana dal naturalismo di Zola e influenzata almeno parzialmente dal Simbolismo. Proprio perché scrittore dilettante, libero da preconcetti estetici, Proust era in grado di proporre la novità di un’opera che è il romanzo di un romanzo (e dunque di un romanziere), come si scopre alla fine della narrazione. Un’opera volta a riconoscere all’arte un valore religioso.
Arriva al cuore del pensiero e della poetica di Proust «Sapere contro vedere. Metamorfosi e metafora», il terzo saggio della raccolta. Qui Orlando ripercorre le tre scene voyeuristiche della Recherche (quella lesbica di Mountjouvain, l’accoppiamento di Jupien e Charlus nel cortile dei Guermantes, la fustigazione nel bordello di Jupien in piena Grande Guerra) cogliendo un collegamento che rende evidente la trasmissione del senso di colpa da chi agisce a chi osserva il sesso sadico-omosessuale. La dissociazione tra vedere e sapere è evidente in molte altre parti del romanzo e qui non è possibile riassumerle; basti però riferire ciò che Orlando ipotizza in merito all’esperienza suprema dell’estasi metacronica dovuta alla memoria involontaria, in cui, in mancanza di un vedere, c’è spazio per un sentire o un percepire anteriore al sapere. La stessa madeleine sollecita il gusto del Narratore e provoca un ricordo involontario, mentre, al contrario, il sapere dovuto ai Nomi si rivela nel corso dell’opera illusorio quanto fascinoso.
Dopo l’analisi di una lettera di Charlus nel quarto saggio («Logica falsa e prestigio vano: una lettera di M. de Charlus», 1983), in cui Orlando valorizza la comicità nel romanzo, si passa a «Proust, Sainte Beuve, e la ricerca in direzione sbagliata», testo pubblicato due volte, rispettivamente nel 1970 e nel 1974. Qui l’analisi ha come oggetto la genesi del testo e si sofferma sulle caratteristiche di «Contre Sainte-Beuve» (apparso nel 1954), che è contemporaneamente un abbozzo del romanzo e un saggio teorico, caratteristiche rapportate alla Recherche, di cui l’autore studia costanti e varianti. Le conclusioni a cui giunge Orlando sono numerose e mettono in risalto la continuità tra le due opere; in estrema sintesi si può dire che la “direzione sbagliata” presa da Sainte-Beuve (dispersiva, memorialistica) minacciava in realtà l’artista creatore (del quale viene valorizzato il ricordo involontario) e nella narrazione la scoperta da parte del Narratore della propria vocazione letteraria.
Una sintesi così stretta dei due libri, priva di citazioni e di una contestualizzazione più ampia, non rende loro abbastanza giustizia, ma lo scopo di questi due articoli è quello di orientare il lettore fornendo un minimo di informazione. Ciò vale anche per i prossimi due testi, che saranno presentati nel secondo articolo:
- Gennaro Oliviero, Il mio Proust, Il ramo e la foglia edizioni 2022;
- Stefano Brugnolo, Dalla parte di Proust, Carocci editore 2022.
Si è concluso lo scorso gennaio il nostro gruppo di lettura dedicato alla Recherche; se vuoi recuperare le dirette con cui abbiamo ripercorso gli snodi tematici e narrativi dell’opera, clicca su: GdL Proust ritrovato
Se invece non vuoi perderti le nostre recensioni, puoi abbonarti alla newsletter, è gratis. Lascia qui sotto la tua mail:
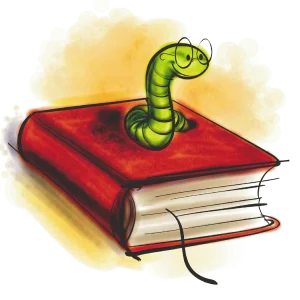
[…] È questa la seconda puntata di una serie di due articoli dedicati alla saggistica proustiana; potete trovare il primo articolo qui: ANCORA PROUST, PER APPROFONDIRE (consigli di lettura di Vittorio Panicara: prima parte). […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] Nel secondo articolo ANCORA PROUST, PER APPROFONDIRE (consigli di lettura di Vittorio Panicara: seconda parte) Vittorio recensisce altri due saggi dedicati all’opera proustiana: Il mio Proust di Gianni Oliviero e Dalla parte di Proust di Stefano Brugnolo. Questo contributo era stato preceduto da uno precedente che potete recuperare qui: ANCORA PROUST, PER APPROFONDIRE (consigli di lettura di Vittorio Panicara: prima parte). […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] ANCORA PROUST, PER APPROFONDIRE (consigli di lettura di Vittorio Panicara: prima parte). ANCORA PROUST, PER APPROFONDIRE (consigli di lettura di Vittorio Panicara: seconda parte). Il mio questionario proustiano: volete provare anche voi? Proust ritrovato: a ciascuno il suo […]
"Mi piace""Mi piace"