È possibile impiegare un termine, cercando di analizzare una situazione politica o di persuadere un pubblico, senza essere in grado di precisarne il concetto? Ovviamente no, se non si vuole ingannare il prossimo (e magari anche se stessi). E se l’esigenza di una definizione scientifica è sempre presente in chi è dotato di onestà intellettuale, è un dovere morale spiegare esattamente un termine che oggi è più che mai attuale e diffuso. Non si può intraprendere una qualsiasi analisi politica del mondo d’oggi assumendo il concetto di populismo in modo generico. Ecco alcuni esempi di uso indifferenziato: nella campagna elettorale del 2015-2016 sia Trump che Sanders sono stati accusati di essere “populisti”, lo stesso vale per personaggi come Marine Le Pen e Geert Wilders e, dall’altro versante politico, per movimenti come Syriza e Podemos; populisti tra gli altri sarebbero Beppe Grillo e Erdogan, due persone evidentemente diverse. La confusione è evidente (a cosa serve un concetto così vago?) e una teoria comunemente accettata di «populismo» non esiste.
Il primo capitolo di « Che cos’è il populismo?» di Jan-Werner Müller, professore di Politica alla Princeton University, inizia con questa citazione (del 1969!): «Uno spettro s’aggira per il mondo: il populismo» (G. Jonescu, E. Gellner). Il libro di Müller, pubblicato in Italia dall’Università Bocconi di Milano nel 2017, approfondisce il problema e tiene conto di tutte le principali posizioni teoriche maturate negli ultimi anni. È quindi il testo ideale per fare il punto della situazione in modo aggiornato e ne riassumerò i contenuti per sommi capi, discutendoli in un altro articolo alla luce dell’attualità politica. Trascurerò i riferimenti al populismo non recente (quello russo, per esempio), che ha poco in comune con il fenomeno in questione.
Un’altra premessa è necessaria. Müller prende le mosse dalla nota definizione del politologo olandese Cas Mudde (Cambridge, 2016), secondo cui il populismo è «una risposta democratica illiberale al liberalismo antidemocratico» dell’establishment presentato come corrotto; sarebbe perciò una sorta di correzione di una politica allontanatasi troppo dal “popolo”, che come tale è sempre onesto. In altre parole, chi è “in basso” ed è rimasto escluso dal potere e dai privilegi di coloro che sono “in alto” – l’establishment con le sue élite – trova nel populismo una forza democratica che rivendica i suoi diritti; la contrapposizione alto-basso sostituirebbe la classica coppia sinistra-destra ed ecco perché esisterebbe il populismo di sinistra e il populismo di destra: secondo Cas Mudde idee di destra o di sinistra possono essere adoperate indifferentemente in difesa del “popolo”. Il populismo non disporrebbe di una dottrina codificata ma avrebbe una sua tipica logica interna; l’esame dei suoi modi postula inoltre i mali odierni della democrazia rappresentativa.
Il discorso di Müller procede attraverso tre momenti distinti:
- la confutazione delle teorie sbagliate, considerate tutte riduttive (i vicoli ciechi),
- le caratteristiche del populismo (cosa dicono e cosa fanno i populisti),
- cosa fare nei loro confronti: Come occuparsi dei populisti.
1) Gli errori da evitare.
Come prima cosa Müller denuncia i “vicoli ciechi” in cui la ricerca si è spesso cacciata. Per lui sono errati il ricorso a «demagogia» come sinonimo di populismo, l’attenzione a determinati gruppi socioeconomici, come la piccola borghesia, la caratterizzazione emotiva del fenomeno (rabbia, frustrazione, ansia e desiderio di una vita “premoderna”), l’inevitabile irresponsabilità delle politiche populiste. In merito a tali spiegazioni, che considera sempliciste, l’autore dimostra come il populismo non possa essere ridotto a una sola di queste qualità, perché in realtà è molto più complesso.
2) Le caratteristiche.
Nella parte centrale del testo, vagliando i contributi di molti studiosi, Müller trova in tutti costoro delle costanti, ovvero i tratti essenziali del populismo, qui elencati in rapida sintesi.
- La critica serrata alle élite in quanto rappresentanti dell’establishment, spesso effettuata da un leader carismatico e autoritario, magari in una situazione di debolezza politica del sistema. Il leader, se come tale è l’interprete del “popolo”, può permettersi anche di appartenere lui stesso a una elite (Trump, per es., o Blocher), in quanto in possesso di un mandato imperativo (sempre in nome del “popolo”), e potrebbe stipulare un “contratto” con i futuri governati (Berlusconi, Haider). La subordinazione al leader, in un movimento populista, è completa.
- La rivendicazione morale di rappresentare in modo esclusivo il “popolo”, quello autentico, che in quanto tale è sempre virtuoso e puro; il populismo è una visione moralistica della politica. Se il “popolo” è una sorta di simbolo, di corpo mistico, da contrapporre nella sua purezza al potere regolato dalla Costituzione, il populismo è di conseguenza insofferente alle procedure del potere, alla divisione dei poteri e al liberalismo in generale (come ad es. il Tea Party negli Stati Uniti).
- Una politica identitaria e anti-pluralista: il “vero popolo” è il Volkgeist, la «vox populi», non l’espressione parlamentare della «volontà generale» (la maggioranza che esce dalle urne). Sono i casi dell’Ungheria con Orban e dell’ Austria con Strache. La rivendicazione fondamentale del populismo è una forma moralizzata di antipluralismo. L’autore sottolinea la pericolosità dell’antipluralismo: se si compromette lo Stato di diritto si mette a repentaglio lo stesso fondamento democratico dello Stato (il populismo distorce il processo democratico).
Gli effetti di tutto questo si notano in un’amministrazione populista (il populismo al potere), propensa ad appropriarsi dell’apparato statale, magari riscrivendo la costituzione, a favorire corruzione e clientelismo e a polarizzare i conflitti.
Fin qui le tesi di Müller, vediamone ora le conseguenze pratiche.
3) Come occuparsi dei populisti.
Per prima cosa non è opportuno ignorare i populisti, per non aumentare il senso di abbandono provato da chi li vota per opporsi alle élite e all’establishment. La democrazia non riesce a rappresentare più questi cittadini, che si sentono messi da parte, e il populismo ne approfitta, come è successo negli Stati Uniti con i Tea Party e l’elezione di Trump.
Un’altra situazione critica si presenta quando nella società prevale una scelta di chiusura identitaria: quando predomina una politica delle identità, i populisti prosperano. (È il caso dell’AfD in Germania e della Lega in Italia.)
Un ulteriore problema nasce dalla vicinanza tra populismo e tecnocrazia, come è avvenuto con l’approccio dell’UE all’Eurocrisi (per esempio nel modo durissimo in cui è stata trattata la Grecia di Tsipras). Sia tecnocrazia che populismo propongono un’unica soluzione politica, alternando moralismo e iniziativa imprenditoriale (lo Stato-azienda berlusconiano, per esempio) ed escludendo qualsiasi dibattito democratico (lo strapotere della troika nell’UE).
Sia il Washington Post che Nadia Urbinati sintetizzano lo studio di Müller riconoscendo tre caratteristiche salienti del populismo: antielitarismo, antipluralismo (la vera novità) ed esclusività. In fondo è il senso della degenerazione della democrazia in crisi di rappresentanza. Secondo la Urbinati
Per comprendere il populismo dobbiamo tenerlo sempre associato alla leadership personale e alla sua rivendicazione di rappresentanza.
La triade antielitarismo, antipluralismo ed esclusività include dunque i tre parametri che permettono di giudicare il grado di populismo di una forza politica. Ma a questo punto mi pare legittima un’obiezione. Per Müller il populismo è una logica di potere, un modo di fare politica, ma in realtà i tre suddetti criteri, molti e complessi, sembrano più i contenuti di un programma politico (di destra!) che modi operativi o condizioni formali dell’agire politico; si pensi all’individuazione dell’establishment e delle elite come responsabili dell’oppressione del “popolo”, o all’autoritarismo dei leader, pronto a restringere le prerogative costituzionali, o all’antipluralismo.
Ma per formarsi un’opinione fondata su un problema così complesso servono altri apporti teorici.
Uno studioso italiano, Marco Revelli, ha ripreso ultimamente il discorso sul populismo del XXI secolo chiamandolo «Populismo 2.0». Ne parleremo nel prossimo articolo.
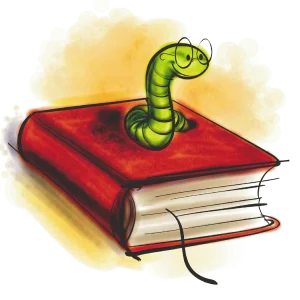
[…] «Che cos’è il populismo?»: la risposta di Jan-Werner Müller (recensione di Vittorio Panicara). […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] https://giornatedilettura.wordpress.com/2018/04/12/che-cose-il-populismo-la-risposta-di-jan-werner-m… […]
"Mi piace""Mi piace"
[…] https://giornatedilettura.wordpress.com/2018/04/12/che-cose-il-populismo-la-risposta-di-jan-werner-m… […]
"Mi piace""Mi piace"